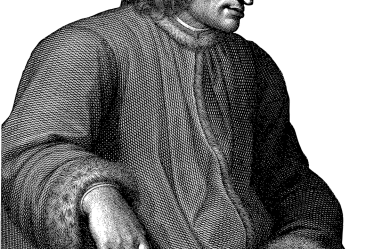the collage post
Il codice dell’anima di James Hillman e la teoria della ghianda
Tutti quanti noi abbiamo sentito almeno una volta nella vita una vocazione.
Nonostante le offese precoci ogni individuo ha un carattere ben delineato con alcuni tratti che lo distinguono sin dalla nascita.
Sicuramente sussiste un motivo se si è venuti al mondo con queste caratteristiche.
Secondo Hillman si può tracciare la trama della propria vita distaccandosi dallo schema nascita, crescita e morte.
Per trovare l’immagine innata occorre una teoria psicologica che attribuisca realtà psichica primaria alla chiamata del destino.
Secondo Hillman la chiave di accesso alla struttura della personalità riguarda la ghianda, e gli errori che in passato abbiamo compiuto nel rapportarci con essa.
Il paradigma per interpretare le vite umane individuali tiene conto solo della genetica e dell’ambiente ma non prende in considerazione quella cosa chiamata “me”.
Hillman sostiene che per liberarci dal ruolo della vittima occorre capire che l’uomo eroe che si è fatto da sé e la vittima sono due facce della stessa medaglia.
La ghianda è la commistione della vocazione, del destino, il carattere e l’immagine innata.
Il tempo va accantonato, non bisogna pensare ad un prima e ad un dopo.
La nostra vita deve essere vista come un quadro: nessuno di noi guardando il quadro si chiede quale parte il pittore abbia dipinto prima o dopo. Tutti i particolari del quadro li vediamo simultaneamente.
L’idea di Platone (il quale prese spunto dal mito di Er) è la seguente.
Prima della nascita l’anima di ciascuno di noi sceglie un’immagine, che poi vivremo sulla terra, e riceve un compagno che ci guida, chiamato “Daimon”.
Nel venire al mondo ci dimentichiamo di tutto questo. È il Daimon che ricorda il contenuto della nostra immagine è lui il portatore del nostro destino.
Sempre secondo Platone il mito ha una funzione salvifica.
Il mito svolge una funzione psicologica di redenzione, e una psicologia derivata dal mito può ispirare una vita fondata su di esso.
Il mito porta anche a delle mosse pratiche, che sono:
- Riconoscere la propria biografia.
- Riconoscere la vocazione come dato fondamentale dell’esistenza umana.
- Alienare la nostra vita su di essa.
- Trovare il buon senso di capire che le situazioni spiacevoli contribuiscono a realizzare il proprio destino.
Il Daimon sarebbe una sorta di angelo custode che non ci abbandona mai.
La teoria della ghianda dice che io e voi siamo venuti al mondo con un’immagine che ci definisce. Il Daimon ha a cuore il nostro interesse.
Possiamo dire che la teoria della ghianda si pone come una psicologia dell’infanzia affermando l’unicità del bambino che porta in sé il suo destino.
La vocazione si esprime nei capricci e nelle ostilità, nelle timidezze e nelle ritrosie del bambino. La chiamata al proprio destino si fa sentire in modo diverso perché per ciascuno non sussiste un modello standard di chiamata.
Qualunque sia la chiamata il Daimon assume una posizione di dignità. Per questo anche un bambino debole reagisce alle cose che ritiene ingiuste con molta forza.
La teoria della compensazione dice che le proprie superiorità trovano radici in inferiorità iniziali.
Secondo Hillman tale teoria uccide lo spirito derubando le persone della loro autenticità.
Le superiorità sono l’espressione di un’immagine più pregnante. Esiste un ideale che richiama a qualcosa che può rimanere vago.
Una visione dei bambini che abbiamo tutti è quella di reputare geniali i bambini nei primi anni di vita. Questo secondo Hillman avviene perché il bambino è tutt’uno con il proprio Daimon, il quale sostiene il bambino.
A questo punto possiamo affermare della teoria della ghianda che ciascuna vita è formata dalla propria immagine unica e irripetibile, un’immagine che è l’essenza di quella vita e che la chiama a un destino. In quanto forza del fato, l’immagine ci fa da nostro Daimon, il quale ha una funzione di promemoria.
Il Daimon è dotato di prescienza, ossia ha un potere in senso generale della vita in cui si incarna. Egli è immortale perché non ci lascia mai.
La nostra discesa a questo mondo la possiamo spiegare tramite il mito di Er, il quale racconta quanto segue:
Le anime prima di venire al mondo hanno una sorta di destino da compiere, una parte assegnata che corrisponde al carattere di quell’anima.
Il Kleros viene lasciato cadere ai piedi delle anime, le quali scelgono il proprio.
Questo mito dice che l’anima discende in quattro modi: attraverso il corpo, i genitori, il luogo, le condizioni esterne.
- Discendere con il corpo significa ubbidire alla legge di gravità e invecchiare.
- Discendere tramite i genitori significa far parte di un albero genealogico.
- Discendere nel luogo significa essere legato a quel luogo con doveri e usanze.
- Discendere tramite le condizioni esterne significa restituire all’ambiente ciò che ti ha dato.
Secondo la teoria della ghianda è stato il mio Daimon a scegliere i genitori e la loro unione deriva dalla mia necessità di venire al mondo.
Il Daimon che sceglie in anticipo i genitori.
Hillman sostiene che i malesseri dei bambini non sono dovuti ad un disfunzionamento genitoriale di cui non hanno colpa i genitori, ma sono imputabili gli antenati.
I genitori carnali hanno filtrato l’idea di antenato. Per alcune civiltà l’antenato può essere un orso, un pesce, uno spirito venuto in sogno.
In quanto spiriti, gli antenati hanno rapporti con altri spiriti, con la comunità nel suo insieme, con le cose con cui convivono.
La ghianda non è visibile neanche al microscopio, pertanto essa è invisibile.
Poiché la ghianda è invisibile occorre costruire un ponte tra noi e la ghianda.
Secondo Hillman esistono tre tipologie di ponti tra il visibile e l’invisibile: la matematica, la musica e il mito.
Le storie che i miti ci raccontano non possono essere storicamente documentate.
Dietro la forza di tutti i miti sussiste un universo di entità invisibili. Il mito è una mescolanza di verità e di fantasia poetica.
Noi viviamo circondati dall’invisibile che ci dà continuamente ordini, come ad esempio i valori della famiglia.
Un metodo per capire l’invisibile, ossia la ghianda, è l’intuizione.
Quest’ultima comprende anche quello che Hillman ha chiamato sensibilità mitica, perché quando un mito ci colpisce, esso sembra la verità e ci fa vedere le cose da dentro.
L’intuizione è una percezione chiara, fulminea, e completa il suo tratto distintivo essendo l’immediatezza del processo. Le intuizioni arrivano senza passaggi logici coscienti o processi di pensiero riflessivo.
Le intuizioni possono essere completamente sbagliate e mancare il segno. Esse possono indicare una via ma non garantiscono delle azioni rette e nemmeno delle corrette percezioni.
Per afferrare il mito occorre l’intuizione. La pertinenza e l’importanza di un mito per la nostra vita ci colpiscono come una rivelazione o una proposizione assiomatica, che non può essere dimostrata con la logica o indotta da prove fattuali. La prova migliore è l’aneddoto, l’esempio rivelatore che illumina un’idea oscura con il bagliore improvviso di un lampo di intuizione.
I filosofi neoplatonici elencano un’infinità di angeli, arcangeli e daimones. Il mondo era un luogo molto permeabile, abitato sia da corpi fisici sia da corpi immaginali. Il progressivo venir meno del nostro interesse verso le cose che la coscienza razionale chiama magiche, mistiche e mitiche hanno fatto sì che tutti i corpi immaginali finissero per fondersi in modo indiscriminato nel mostruoso. Il risultato, l’invisibile, diventa l’alieno.
L’alienazione rende l’invisibile ancora più pauroso. La cosa che mi fa paura mi fa commettere azioni folli; magari l’invisibile è il mondo del demonio e bisogna starne alla larga.
Secondo Hillman occorre costruire un ponte tra il visibile e l’invisibile. Questo ponte è la figura di Gesù Cristo.
Egli è il Dio invisibile che prende in prestito una forma umana, la quale è visibile. Lo Spirito Santo tiene unite le due parti. Lo Spirito Santo che è invisibile.
Il momento più patologizzato di tutto il racconto della Incarnazione è quello del grido sulla croce che dice l’angoscia lacerante di quando si è circondati soltanto dal mondo visibile. Gesù aveva avuto nemici intorno per tutti i trentatré anni della sua vita, era stato combattuto e perseguitato, ma mai si era sentito bloccato come in quel momento. Il mondo degli uomini, della natura e delle cose era diventato selvaggio e ostile. Prima di allora il mondo era stato permeato di Invisibilità, una condizione che la cristianità definì paganesimo. Quando l’invisibile abbandona il mondo quotidiano, allora il mondo visibile non può alimentare la vita perché la vita non ha più il suo sostegno invisibile. Allora il mondo ti dilania.
La compresenza di visibile ed invisibile è ciò che alimenta la vita.
Esse est percipi disse il filosofo irlandese Berkeley. Noi siamo e diamo esistenza in virtù della percezione. La percezione pone in essere l’essenza di ciò che percepiamo e quando la percezione vede nella santità degli affetti del cuore, si disvelano cose che dimostrano la verità dell’immaginazione.
La psicologia scientifica taglia il regno delle cause in due parti, che sono natura e cultura. Ed elimina un qualcos’altro.
Questo modo di pensare è tipico della cultura occidentale.
In fondo, a tutti noi risulta con chiarezza, dall’evidenza dei nostri sentimenti e di personalissimi eventi, che nella vita umana interviene qualcos’altro che non può essere contenuto né dentro la cultura né dentro la natura.
La straordinaria singolarità degli individui, anche tra gemelli, avviene grazie all’ambiente.
Già l’ambiente condiviso è pieno di differenze. Prendiamo ad esempio i gemelli che hanno con la propria madre un rapporto diverso.
L’unico spazio non condiviso è l’unicità del Daimon e l’individualità della mia relazione con lui.
Dopo aver scelto i genitori ed essere venuti al mondo, il Daimon deve essere nutrito tramite le fantasie dei genitori.
Il clima meno salutare per il nostro Daimon, che cerca di vivere con i nostri genitori nel luogo e nelle situazioni che loro ci hanno dato, si crea quando i nostri genitori non hanno nessuna fantasia su di noi. I cosiddetti bravi genitori si astengono da fare fantasie sui figli: ciascuno deve vivere la propria vita e decidere autonomamente. Queste secondo Hillman sono delle idiozie.
I figli non fuggono dall’autoritarismo dei genitori o dalla loro confusione, ma fuggono dall’assenza di fantasie che non siano quella di fare compere, lavare, scambi convenzionali.
Sono meglio quei genitori che proiettano sul figlio le proprie fantasie e cercano in tutti i modi di realizzarle, perché la ghianda del bambino ha delle sfide da superare, una realtà contro cui combattere, la realtà delle fantasie dei genitori, che può portare a smascherare la superstizione parentale stessa, a vedere che io non sono condizionato dai miei genitori, non sono il loro risultato.
La ghianda è ossessiva. È tutta e solo concentrazione, come una goccia di essenza che non si può diluire. Il bambino mette in gioco il codice germinale che lo spinge a queste attività ossessive.
Il doppelganger è un personaggio che è il gemello, il mio alter ego, la mia ombra, un altro me stesso, una mia immagine che sembra starmi vicino. Egli si manifesta quando parliamo da soli, quando ci rimproveriamo, ci esortiamo alla calma.
Questo gemello immaginario si manifesta nella scelta del nome composto, nome doppio, nome di un avo. Anche nei soprannomi egli si manifesta.
Le bibliografie rendono visibile il rapporto tra i due nomi e noi e si vede il proprio Daimon.
Se il Daimon sceglie la nostra vita quale capacità decisionale ci rimane?
La vita di ciascuno di noi è già scritta nella ghianda e noi non facciamo altro che realizzare il piano segreto inciso nel cuore. Il Daimon non predetermina il singolo evento della vita. Per i greci la causa di infausti eventi sarebbe il fato, il quale è una momentanea variabile che si interrompe.
Il termine greco per indicare il fato, moira, significa parte assegnata, porzione. Così come il fato ha solo una parte in ciò che ci succede, allo stesso modo il Daimon, l’aspetto personale, interiorizzato della moira, occupa solo una porzione della nostra vita, la chiama ma non la possiede.
La ghianda segue uno schema circoscritto. Non indulge in filosofie di ampia portata.
Ti fa battere il cuore, in un eccesso di rabbia. Eccita, chiama, pretende, ma raramente offre uno scopo grandioso.
La forza di attrazione dello scopo è intensa e improvvisa; ci si sente molto risoluti. Ma in cosa consiste lo scopo e come avvicinarsi rimane vago.
Lo scopo di solito non si presenta come una meta nettamente inquadrata, bensì come un’urgenza indefinita che turba, unita a un senso di indubbia importanza.
Il Daimon infonde a quei particolari eventi un senso di importanza emotiva che sono un annuncio del destino.
La ghianda si comporta come uno stile mobile, una dinamica interna che conferisce alle occasioni il sentimento.
Non bisogna chiederci che scopo abbia l’imprevisto a cercare il valore dell’imprevisto.
Saggezza in greco era sophia, aveva un significato particolare riferito in origine alle arti che richiedono destrezza manuale, in particolare all’arte del timoniere.
La destrezza del timoniere si manifesta nell’arte di compiere minimi aggiustamenti con la barra del timone. Il Daimon, facendo costantemente la stima di eventi che sembrerebbero farci deviare dalla nostra rotta, insegna questo tipo di saggezza.
Gli shock non possono deteriorare la ghianda, perché quel fatto è necessario per far emergere la vocazione.
La necessità opera come una causa mutevole.
La scelta che facciamo è quella richiesta dalla necessità, ossia nell’istante che compiamo una decisione è necessaria.
Le cose non avrebbero potuto essere altrimenti.
Le persone particolarmente malvagie hanno una ghianda o hanno una ghianda danneggiata: nel primo caso come è la ghianda?
O si può prevenire la crudeltà di alcune persone”: questa frase non si concorda con il resto.
Hillman sostiene che si possa intervenire tramite un equilibrio tra la debolezza della psiche e la potenza del Daimon, tra la chiamata trascendente e la personalità alla quale essa si rivolge.
Lo sforzo di discendere per crescere fa slittare il punto focale della personalità dall’egocentricità monomaniacale del daimon verso la comune umanità, distorcendo la chiamata della trascendenza all’espansione dentro il mondo con le sue esigenze.
La prima cosa da fare è riconoscere l’esistenza del Daimon, il quale vuole essere riconosciuto e presto avere il posto che merita.
Per male si intende un caparbio egocentrismo narcisista in una arroganza senza limiti.
I greci chiamavano hybris l’arroganza senza limiti ed essa è indicata come superbia.
Per prima cosa occorre un rituale con un effetto sedativo, incominciare con il lutto.
Anche se non c’è rimorso per gli atti malvagi commessi, si può indurre una crescente consapevolezza del Daimon che li ha eseguiti.
La seconda fase è la rinascita, la svolta di direzione del servizio alla collettività come viene fatto in molti casi: ex detenuti vanno nelle scuole a parlare delle loro condotte per evitare ai giovani il loro stesso destino.
La nostra idea di ritualità suggerisce modi concreti per rispettare la potenza della vocazione. Suggerisce discipline intrise di valori più che umani i cui riti saranno toccati dalla bellezza, trascendenza, avventura e senso della morte.
La teoria della ghianda afferma che ciascuno di noi è un eletto perché ha una ghianda unica e irripetibile che caratterizza ogni persona.
Occorre fare delle precisazioni sulla mediocrità e il carattere.
La mediocrità significa non avere tratti distintivi.
Il carattere non è ciò che si fa ma come lo si fa.
Il Daimon diventa la sorgente dell’etica umana e la città felice che i greci chiamavano eudaimonia, è la vita che va bene per il Daimon.
E come il Daimon, che chiamandoci ci dispensa un bene prezioso, una benedizione, così facciamo noi con lui attraverso lo stile con cui lo seguiamo.
Il Daimon parrebbe essere non soltanto platonico ma anche democratico, in quanto entra nel mondo delle intenzioni, si manifesta nella geografia.